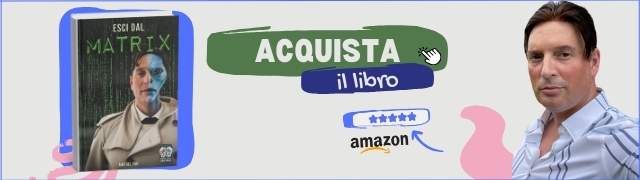Il libro di Morris San che il lettore stringe tra le mani presenta un obiettivo emancipativo fondamentale, che lo pone in connessione con la migliore filosofia prodotta dalla tradizione europea. Fin dal titolo – “Esci dal Matrix” – dice con chiarezza adamantina l’obiettivo e la situazione di partenza: l’umanità figura oggi come prigioniera del Matrix e, conseguentemente, compito principale del pensiero deve essere produrre l’emancipazione o, se si preferisce, la fuga verso realtà diverse e migliori.
Il compito, già di per sé arduo, dell’uscita dalla prigione e reso ancor più difficile dalla circostanza per cui la massima parte degli esseri umani ignora la propria condizione e, assai spesso, scambia le proprie catene per la libertà o, comunque, per la sola realtà possibile. Morris San lo mette in evidenza fin dalle prime pagine, allorché scrive quanto segue:
“questo libro non è per tutti.È destinato all’1% della popolazione o a quella minima parte del 99% che desidera davvero cambiare vita. Al suo interno troverai scritti che potrebbero sembrare usciti da un film fantascienza, ma che potrebbero contenere più verità di quanto immagini”.
Con queste parole, l’autore si colloca idealmente nel solco di quella nobile tradizione che, a partire da Platone, ha immaginato la fuga verso migliori libertà come obiettivo del pensiero e dell’azione, saldando inscindibilmente tra loro le due istanze della verità e della liberazione. Il fabula docet che traiamo dall’allegoria platonica dell’antro caliginoso e umbratile al centro del settimo libro della “Repubblica” è, in effetti, anche questo: non si può uscire dalla spelonca o, direbbe Morris San, dal Matrix, se prima non si sia compresa appieno la propria condizione di prigionieri e, con essa, la preferibilità del mondo esterno rispetto a quello circoscritto dai perimetri della gabbia in cui i più sono senza saperlo.
Senza esagerazioni, mi avventurerei a sostenere che la storia della nostra Europa non è altro che una infinita rimodulazione del teorema di Platone e della sua unione simbiotica tra verità e liberazione: dalla programmatica dichiarazione dei vangeli, secondo cui “la verità vi farà liberi”, fino alla icastica definizione kantiana dell’illuminismo come Ausgang, come “uscita” dalla condizione di minorità che dobbiamo imputare a noi stessi, fino naturalmente a Marx e alla sua promessa di emancipazione universale: da perdere solo le catene, da guadagnare un mondo.
Ora, la liberazione dalle catene simboliche, spirituali o culturali che dir si voglia risulta ancor più essenziale rispetto a quella dei ceppi materiali che ci rendono oggi schiavi di un sistema tecnocratico in cui tutto e tutti sono sacrificati sull’altare del fare produttivistico e del profitto illimitato gestito autocraticamente dall’apparato stesso. Solo compiendo quella che Platone stesso chiama la “conversione dell’anima” (“Repubblica”, 521 c), e dunque la rivoluzione simbolica in grado di farci mutare la nostra visione sull’essere, possiamo successivamente intraprendere la difficile via che ci conduce fuori dal Matrix.
Oggi come ai tempi di Platone, lo schiavo ideale è colui il quale figura come ignaro cultore delle proprie catene o, alternativamente, colui il quale ha metabolizzato la convinzione, niente ha fatto neutra, secondo cui quelle catene non possono essere in alcun caso spezzate. In effetti, sull’immaginario antro platonico della nostra contemporaneità scorre senza posa sul fondo la scritta a carattere cubitali there is no alternative, funzionale alla metabolizzazione universale dell’imperativo del ne varietur: la tribù degli ultimi uomini dell’odierna civiltà tecnomorfa si divide equamente tra soggetti che, con ebete euforia, coltivano le proprie catene scambiandole per la migliore delle libertà possibili e individui che, pur coscienti della situazione di irragionevole illibertà in cui vivono, si sono persuasi della immodificabilità dei rapporti di forza e delle condizioni date, di fatto riconciliandosi con l’irrazionalità dilagante e costringendosi a convivere con l’insensatezza fattasi mondo.
Morris San dà forza e concetto al bisogno di fuga dall’antro, risvegliando il senso della possibilità di essere altrimenti ed esortandoci, con passione e competenza, alla conversione dell’anima nell’accezione di Platone. La miseria e l’oscenità del Matrix possono effettivamente essere admbrati solo se ad esse viene contrapposta la migliore situazione di una possibilità alternativa rispetto a ciò che c’è: come suggerito da Sartre in “L’essere e il nulla”, la mezzaluna potrebbe apparire di per sé perfetta, ma si manifesta come incompiuta quando viene comparata con la circolarità perfetta della luna piena.
Fuor di metafora, ciò che c’è risulta imperfetto solo se posto in relazione con ciò che potrebbe esserci a partire da ciò che c’è: in antitesi con le strategie narrative dell’ordine neoliberale, la realtà non si risolve nella pura presenza delle cose date, ma racchiude in sé anche la possibilità di ciò che potrebbe esserci e che, per così dire, dorme nel presente in attesa di essere risvegliato ed essere tradotto in prassi. Ed è quanto ci esorta a fare nel suo saggio Morris San: leggerlo equivale, per ammissione dello stesso autore, a ingerire la pillola rossa, quella che, nella celebre pellicola “Matrix” del 1999, permette a Neo – variante contemporanea del platonico prigioniero liberato – di intraprendere il proprio difficile percorso di liberazione; percorso che, non per caso, muove anche in quel caso dalla consapevolezza della falsità del tutto e dalla conseguente necessità di compiere l’esodo dalle sue strutture alienanti.
“Preparati a un viaggio che cambierà il tuo punto di vista. Dopo questa lettura, il mondo che conosci non sarà più lo stesso”
: così dichiara programmaticamente Morris San, accompagnando per mano il lettore verso la via della liberazione e della fuga dal Matrix, in una prospettiva che, come si evincerà leggendo il suo lavoro, risulta profondamente intrisa anche di temi religiosi (in primis la contrapposizione tra “illuminati luciferini” e “illuminati di Dio”).
Se per certi versi Matrix può risultare ancora più efficace della caverna di Platone, che pure ne costituisce il paradigma originario (gli stessi registi della pellicola erano, come è noto, intrisi di letture filosofiche), ciò dipende soprattutto dal fatto, bene evidenziato da Morris San, che il film del 1999 affronta direttamente il tema della società contemporanea, sospesa tra alienazione e tecnocrazia, tra efficientismo e omologazione: una società distopica che, realizzando le premesse di Orwell, ci rende tutti schiavi inconsapevoli, mere variabili del sistema della produzione. Quanto più ci illudiamo di utilizzare la tecnica, tanto più ne siamo utilizzati e ci sviliamo al rango di suoi docili funzionari.
Come è noto, la pellicola del 1999 metteva a tema, con sobria aderenza, una realtà ormai signoreggiata dalle macchine, nei cui spazi reificati gli esseri umani figuravano ormai soltanto come strumenti manovrati dalla tecnica in vista del suo illimitato autopotenziamento, secondo un tema centrale nella migliore filosofia contemporanea, da Martin Heidegger a Emanuele Severino.
Come si diceva, l’esodo dal Matrix, su queste basi, diventa un’esigenza vitale per riconquistare la propria libertà mortificata dalle spire del sistema tecnocratico e disumanizzante:
“uscire dal Matrix significa riconoscere i limiti del sistema e avere il coraggio di costruire una vita che rifletta i propri valori, aspirazioni e desideri autentici. Significa non accettare passivamente le regole, ma crearne di nuove, più in linea con ciò che vogliamo per noi stessi e per le generazioni future”.
Queste le seducenti parole di Morris San in relazione al compito fondamentale che tutti e ciascuno debbono fare proprio leggendo il testo e comprendendo anzitutto la falsità totale dell’ordine dominante. L’autore si sofferma con attenzione e con sobrio realismo sui tratti massimamente dispotici della nostra società, scandagliandone puntualmente le contraddizioni e le storture: il lettore sperimenterà in prima persona, leggendo le appassionate pagine del saggio, quali e quanti siano gli stratagemmi del Matrix per dominarci e per sfruttarci fino allo sfinimento, peraltro illudendoci di essere massimamente liberi nella nostra condizione di insuperabile schiavitù.
Dopo aver preso in esame i tratti salienti della società reificata (dalle menzogne dominanti al “lato oscuro della sicurezza”, dalla smart city dei 15 minuti ai sofisticati sistemi della manipolazione e della propaganda), e dunque dopo aver delineato le strutture fondamentali del nuovo antro platonico globalizzato, Morris San propone la via della conversione dell’anima e le strategie pratiche per metterla in atto. La narrazione si fa qui autobiografica, come nel “Discorso sul metodo” di Cartesio del 1637: è l’autore in prima persona a raccontarci, “come in un quadro”, per riprendere la locuzione cartesiana, il proprio percorso autobiografico, vale a dire la strada da lui seguita operativamente per compiere l’esodo dalla cattività del totalitarismo glamour della civiltà tecnomorfa.
“Rompere le catene” per guadagnare l'”indipendenza mentale” e, con essa, raggiungere la felicità è la strategia essenziale delineata dall’autore, corrispondente, come già si diceva, al processo emancipativo da lui svolto in prima persona e ora proposto, alla maniera cartesiana, come universale via di liberazione che tutti possono seguire. Le strategie proposte sono molteplici e tutte degne di essere prese seriamente in considerazione: il lettore le affronterà singolarmente nel corso della lettura e potrà valutare egli stesso in prima persona la loro attuabilità.
Due obiezioni si potrebbero muovere a Morris San in relazione al suo lavoro: in primo luogo, gli si potrebbe obiettare che quella da lui proposto, più che un rovesciamento del sistema dominante, si pone come una via di fuga individuale, che non va a stravolgere detto sistema. Insomma, la sua sarebbe una via di liberazione simile più a quella del ribelle di Juenger che a quella della rivoluzione di Marx.
La seconda obiezione potrebbe essere quella di chi facesse notare che la via di liberazione proposta dall’autore finisce in ultima istanza per fare uso, sia pure in una diversa forma, degli strumenti allestiti dallo stesso sistema dominante (YouTube, criptovalute, ecc.).
Si può davvero uscire dal Matrix seguitando a impiegare gli strumenti che esso mette a disposizione? O non sono già quegli stessi strumenti parte integrante della cattività generale?
A queste due pertinenti obiezioni, si potrebbe rispondere – e credo che l’autore stesso risponderebbe – asserendo che, per quel che concerne la prima, la rivoluzione individuale, vuoi anche nella forma della ribellione, può costituire la premessa della rivoluzione generale, se tanti o addirittura tutti la mettono in pratica.
Come nella caverna di Platone, si tratta di proporre a tutti il messaggio di liberazione, anche se non tutti sapranno accoglierlo e tradurlo in prassi conseguente. Insomma, se tutti sapranno agire coerentemente con la strategia delineata da Morris San, il sistema dominante crollerà da sé sotto il suo peso, sciogliendosi come neve al sole.
Alla seconda obiezione, si potrebbe ragionevolmente rispondere che anche l’utilizzo degli strumenti del sistema contro il sistema può essere in certe maniera una via di opposizione all’ordine dominante, soprattutto quando quegli strumenti vengono impiegati secondo orientamenti e finalità che non coincidono e anzi si oppongono a quelle di detto ordine. Era, in fondo, ciò che lo stesso Marx pensava in relazione alla rivoluzione, destinata a sottrarre al capitalismo l’utilizzo dei suoi strumenti, riconvertiti in mezzi di liberazione dell’uomo.
Ciò mi permette di dire, in conclusione, che la proposta di Morris San merita di essere seriamente presa in considerazione e le si deve oltretutto riconoscere l’onestà e il coraggio tipici di chi, anziché genuflettersi all’ordine dominante e accettare le catene con stolta letizia o con depressiva rassegnazione, insorge e si adopera con zelo per produrre piste di fuga dalla irrazionale razionalità tecnocratica: ciò che c’è non è tutto, e più in alto della realtà sta la possibilità. Già solo nel riconoscimento della non-destinalità e della non-eternità del dominio che ogni giorno subiamo vi è un fecondo messaggio emancipativo, che Morris San accoglie e sviluppa in senso originale e gravido di possibili emancipazioni che sarà il lettore a giudicare in prima persona.
In questo senso, la figura di Morris San così come emerge da questo suo pregevole testo mi pare a tratti accostabile a quella del Conte di Montecristo, ennesima variante dell’archetipo platonico dell’antro. Edmond Dantès personifica magnificamente la figura del prigioniero che, fin dall’inizio, è consapevole dell’ingiustizia della propria cattività e, conseguentemente, si batte per riconquistare la libertà di cui è stato privato a opera di un potere maligno che lo ha ingannato e raggirato.
Edmond Dantès è diverso tanto dagli ottenebrati della caverna di Platone – gli schiavi ignari –, quanto dal servo volontario di cui dirà, nella prima modernità, La Boétie con il suo magnifico “Discorso sulla servitù volontaria”, al cui centro troviamo la ripugnante figura del servo che alla pericolosa libertà preferisce la confortevole schiavitù.
Il Conte di Montecristo sa che non si dà libertà entro lo spazio mortificante della sua cella e che dunque la sola libertà, là dentro, consiste nella lotta per la liberazione. Sa anche che, acciocché si possa evadere dalla prigione, bisogna studiarla attentamente, comprenderne i punti deboli, sondarne le crepe, esplorarne i difetti.
Ancora una volta, la liberazione e la verità fanno sistema. Come Edmond, anche Morris San ci guida per mano e ci mostra tanto le contraddizioni del Matrix, quanto la via per uscire “a riveder le stelle”.